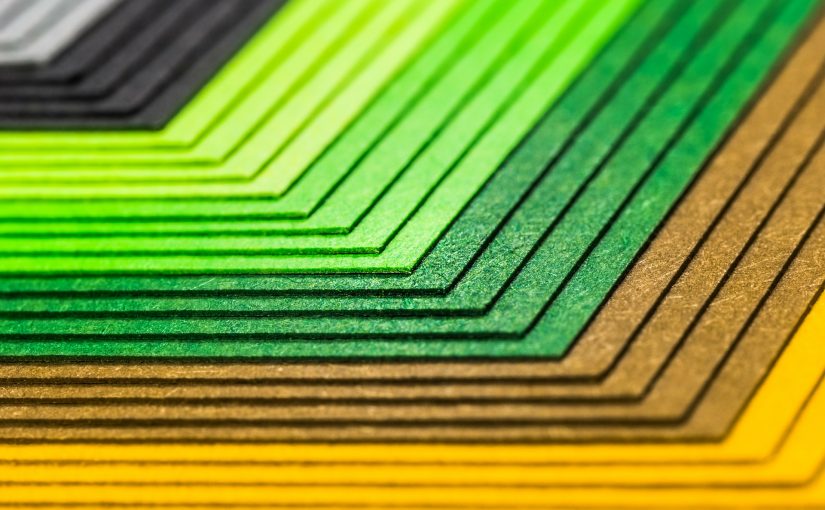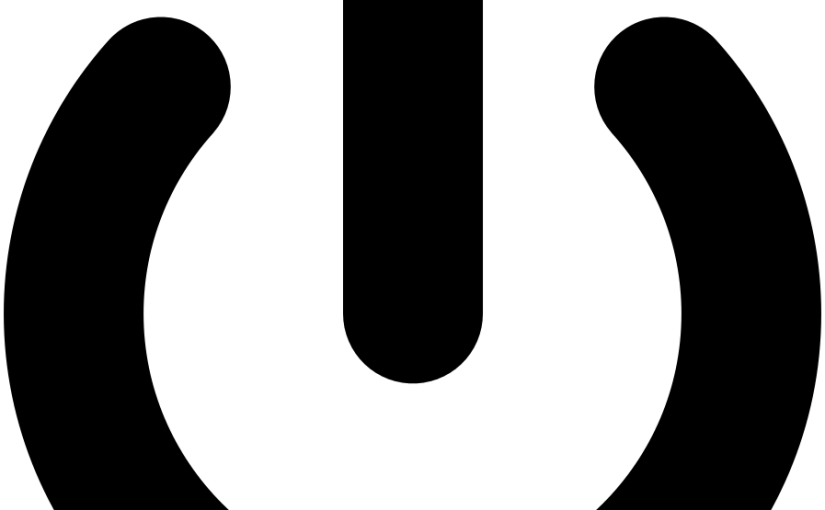Scelgo scarpe comode e, comunque, con le scarpe sbagliate fai poca strada. Questo in generale.
Scelgo scarpe che immagino potrei indossare senza vergognarmene. Quello che offre la moda mi rimbalza, scelgo basandomi su come mi posso sentire portando quelle scarpe abbinate ai vestiti che ho in guardaroba. In verità sono piuttosto concreta: le decolte tacco 16 son belle su qualcun altro, non certo su di me.
Ogni tanto penso ai piedi delle Geishe, vittime della pratica del Loto D’Oro, e penso a quanto dolore venivano sottoposte. Penso che andare lontano con dei piedi così sarebbe stata una Via Crucis, ecco perché era facile tenerle prigioniere. Avrebbero percorso mille miglia correndo avessero potuto farlo, ne sono sicura.
Negli anni ho avuto delle scarpe talmente comode e belle (a mio parere) che le ho consumate a forza di indossarle fino all’ultimo passo possibile. Non riuscivo a rassegnarmi che la nostra storia d’amore fosse costretta a interrompersi. È stato doloroso. Eh, tendo ad affezionarmi alle cose belle.
Tutto questo per dire cosa? Non lo so. Forse sono stata ispirata dalla mia amica sciatica che è ritornata alla riscossa e pretende calzature di un certo tipo. Forse sono infastidita dallo show delle ciabatte estive che non stanno bene a tutti e bisognerebbe tenerne conto. Forse i piedi delle Geishe mi hanno traumatizzato più di quel che pensavo, forse sono irritata dal fatto che non riesco a trovare della scarpe come dico io e mi sono rotta di girare di negozio in negozio sperando nell’incontro del secolo. Forse sono solo in affanno e ho bisogno di una vacanza.
Vabbè.