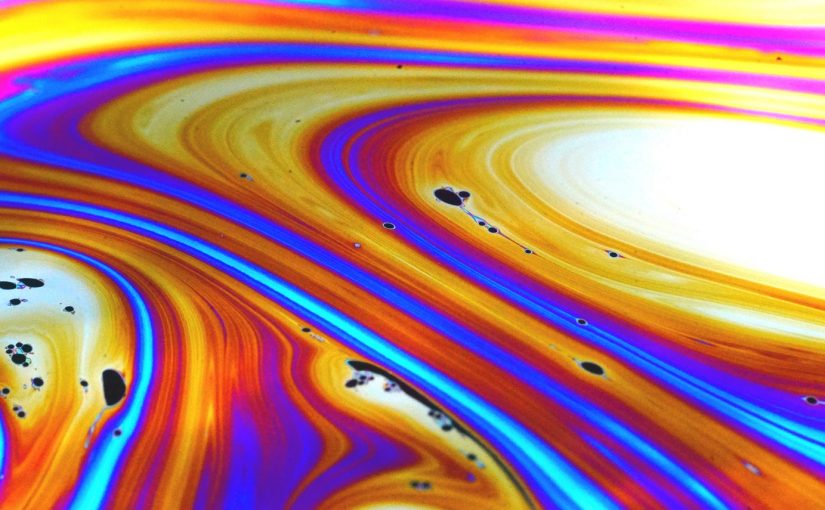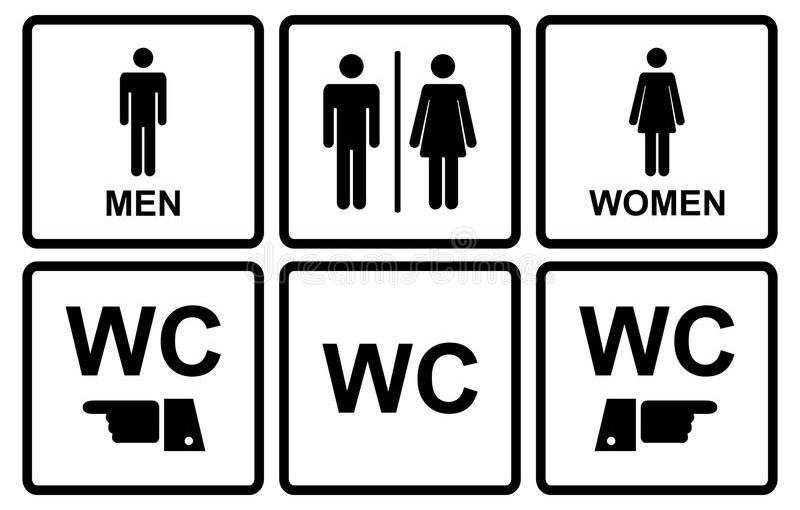Non smettere mai di veleggiare, questo bisognerebbe tenerselo bene a mente. Se getti l’ancora sei fottuto. Questo bisognerebbe tatuarselo ovunque per non pensare di poter far finta di nulla e farla franca.
Chi si ferma è perduto. Raramente i proverbi si sbagliano.
Lo so che la stanchezza ti fa fare scelte di comodo, che sembrano una comodità almeno, ma alla lunga le si paga tutte. La stanchezza è una brutta bestia. Quando sei stanco le cose ti escono dalla bocca in modo sgarbato, fai danni soltanto con un’occhiata di traverso. Quando sei stanco il mondo lo odi a prescindere. Tutto ti dà fastidio. Vuoi solo dormire. E dovresti farlo perché sei veleno allo stato libero che dove si posa fa danno. Dormire aiuta.
Tutte le scelte che fai pensando di mettertela via e stare tranquillo ti si rivoltano contro. Ti sposi perché così ti risolvi il problema di trovare l’anima gemella, ti tieni quell’anima che hai e te la fai andare bene. Chiudi un sogno e ti adegui. Oppure ti fermi al lavoro che ti dà due soldi (sì, soltanto due, ci si vende per poco ormai) e ti fai passare sopra il rullo compressore ogni giorno, tanto più di così non hai trovato e alla fine del mese le bollette si devono pagare. Smetti di veleggiare, smetti addirittura di cercare il vento, smetti di proiettare te stesso sulla rotta che ti eri ripromesso di mantenere per costruirti una vita a tua misura. Soddisfacente. Semplicemente.
Veleggiare costa fatica, il movimento snerva, è vero. L’immobilità, invece, mummifica e non è che si soffra di meno.
Io sono stanca e non so se riuscirò a veleggiare, ma non è che la vita ti chiede il permesso prima di ribaltarti. E la vita non ha pietà. Rendiamocene conto una volta per tutte.
Ok, vado a recuperare la bussola. Chissà dove diavolo l’ho messa…