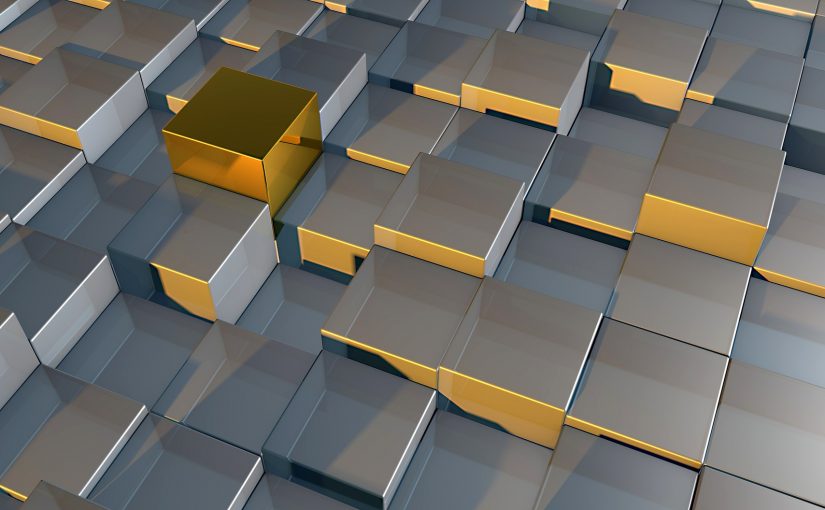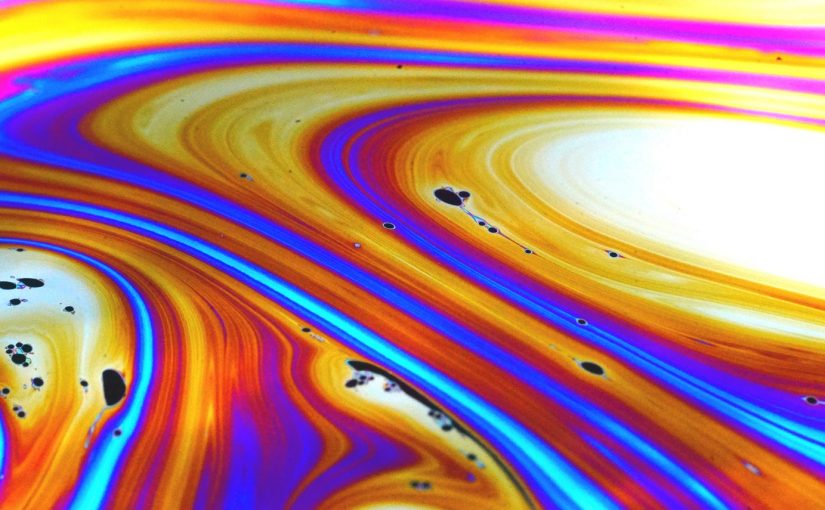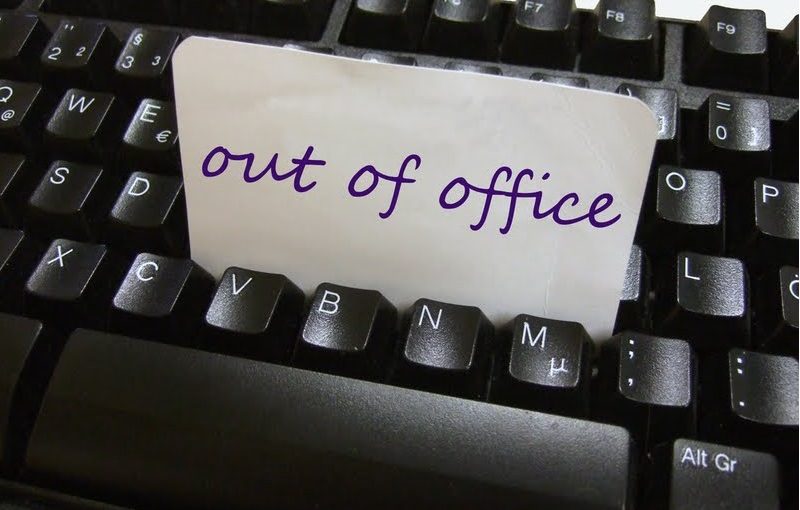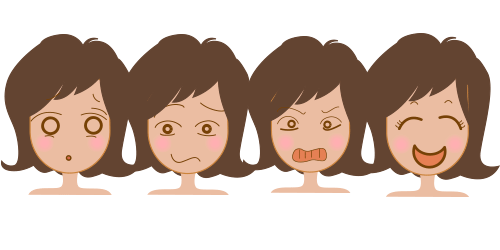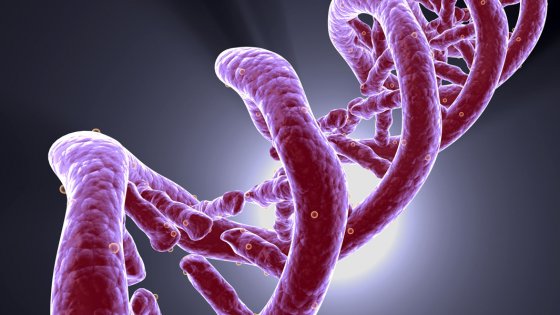A un certo punto si inizia a capire che c’è bisogno di anestetizzarci un po’ per le cose che ci portano scompensi. Soprattutto emotivi, che sono i più fastidiosi perché non colpiscono mai un punto soltanto, ma si propagano fin dove neppure li vedi e son cazzi a sistemare tutto. Quindi, in età pre-adolescenziale inizi ad alzare le spalle, poi impari a farlo con più discrezione distogliendo l’attenzione e pensando ai fatti tuoi e poi chiudi proprio la porta appena ti accorgi che lo scompenso si sta per presentare sulla soglia.
L’anestetico funziona, ci permette di sopravvivere. Ha, come ogni farmaco, anche effetti collaterali obbligatori. Anche brutti. Uno fra tutti è che senti di meno. Senti tutto di meno.
Perché ti anestetizzi ma non è una puntura che fai nel punto che decidi tu, lo spargi dentro di te random e da qualche parte andrà. E lui va. Va dappertutto. Significa che il tuo corpo ogni volta dovrebbe disintossicarsi per ritornare quello di prima, ma una volta che sai come attivare la procedura di addormentamento dei sensi perdi il controllo, la usi a sproposito e non te ne liberi più. L’anestetico sparso ovunque fa il suo mestiere: anestetizza. Ogni parte di te che incontra. Senza pregiudizi, senza cattiveria. Prende quello che c’è e potrebbe prendersi tutto.
Piano piano, ovviamente, e puoi anche non accorgertene. Piano piano, ma in modo sistematico e senza ritorno. A meno che non succeda qualcosa di veramente traumatico che ti risveglia. Una disintossicazione violenta, diciamo.
La vecchia abitudine non muore però e, appena puoi, ritorni all’uso smodato. E non sentire è brutto, non sentire niente dev’essere davvero brutto. Quell’inferno consolatorio di chi ha abbracciato l’indifferenza come filosofia e ha giurato di farla pagare a tutti. Chi c’è c’è.
Evviva.