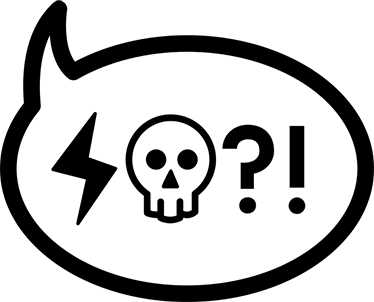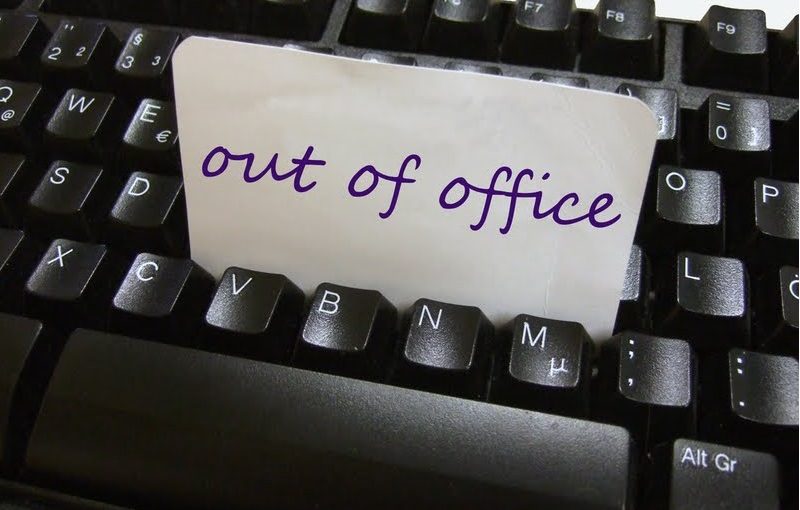Non è bello, lo so. Quando insulti qualcuno è il tuo disprezzo che gli butti in faccia, non è bello. Con arroganza ti poni sopra di lui di almeno tre livelli e gli urli che è un essere inferiore, non è bello. Poi ti senti in colpa, ti rendi conto che potevi risparmiartelo, che come ti diceva tua nonna “ti metti al suo livello e perdi la ragione”, che se avessi fatto un respiro profondo, se avessi canticchiato una canzone, se ti fossi fatto un giro per smaltire il nervoso, se… se… se…
Eppure.
T’è uscito di bocca proprio perché te lo hanno tirato fuori con le pinze, proprio non c’era modo di confrontarsi, di discutere alla pari, di cercare un punto d’incontro per costruire un dialogo. Niente. Niente di niente. E dall’altra parte la tracotanza, la spavalderia, la presunzione, la spocchia, tutto troppo – veramente troppo. Perché c’è gente che non fa così, è così. C’è gente che non si è mai presa un pugno in faccia quando ha esagerato, quando ha tirato fuori la sua immondizia personale per buttarla addosso a qualcuno. Se si fosse preso almeno un pugno si sarebbe fermato a riflettere: oh, che male. Non certo: oh, che coglione che sono, me lo merito. No, quello sarebbe chiedere troppo, ma il dolore fisico ti fa fermare un attimo a riflettere su se stesso (entità, persistenza ecc. – cose tecniche che occupano una certa quantità di neuroni per essere comprese) ed è già qualcosa, no?
L’insulto, in questi casi, è catartico. Raccoglie in sé la potenza dell’esasperazione, l’esaurimento delle scorte di tolleranza, il deficit empatico che quando viene a mancare non ce n’é più per nessuno. L’insulto, quello sentito nelle viscere, quello che fa un sacco di strada prima di uscire dalla bocca perché passa anche dal cervello, insomma l’insulto vero ha bisogno di calma interiore per estrinsecarsi in tutta la sua forza. L’insulto che libera e solleva è quello che non si urla, che non si sputa, che non si involgarisce con un linguaggio becero e non va a toccare le debolezze del destinatario. L’insulto che intendo io è quello che sublima il pensiero e lo porta a un livello tale che chi lo riceve – per via dei pochi neuroni disponibili – manco se ne accorge che è stato offeso. Il tono della voce controllato, il volume impostato su frequenze medio basse, la scelta della parola che non stroppia, che non cola da nessuna parte, che non intacca minimamente la pienezza del concetto che il mittente vuole traghettare e che sente di dover farlo usufruendo di ogni sua risorsa: questo è l’insulto che innalza, innalza chi si prende l’onere di dargli voce e persino chi lo riceve.
Quindi, tutta la masnada di politicanti della domenica che affollano il nostro Parlamento sono davvero dei pivelli, neppure degni di essere presi in considerazione. Hanno zero classe e zero preparazione per quanto riguarda gli insulti, si dovrebbero vergognare. Non hanno mai preso un pugno in faccia e non hanno mai potuto riflettere su quello specifico dolore e tutto il resto.
Poveri loro. Poveri noi.