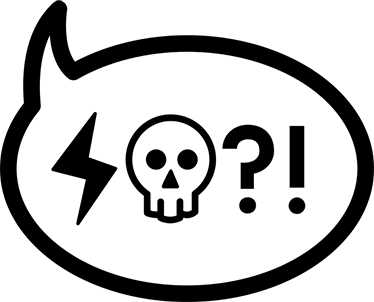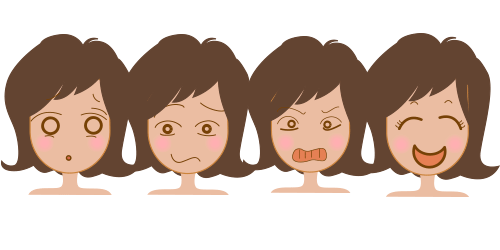Dare accoglienza è uno dei grandi piaceri dell’incontro tra gli Esseri Umani. Noi contemporanei ce lo siamo dimenticato. Sono cresciuta in una famiglia dove all’ospite veniva riservato il cibo migliore, i sorrisi migliori, e il tempo che lui stesso decideva bastasse. Ti mettevi a disposizione di qualcuno che poteva fregarsene di quanto risultava inopportuno o invadente, tu facevi comunque il tuo dovere. Se l’ospite ne approfittava, non riceveva più alcun invito. Ognuno a casa sua.
Questo imprinting è difficile da bypassare, ma non mi dispiace. Parla di totale rispetto dell’altro, in quanto persona ospitata, senza condizioni. Una cosa proprio generosa, una cosa senza senso per i criteri odierni. Ripeto: non mi dispiace affatto di aver imparato a tenere questa posizione, credo sia una grande lezione.
Ho anche imparato, sempre grazie alla mia famiglia, a come ci si deve comportare a casa degli altri: non toccare niente, non parlare ad alta voce, non occupare troppo spazio e non restare per troppo tempo. Il giusto. Seguendo ancora oggi queste semplici regole mi sento a posto con me stessa. Il rispetto non è una parola di concetto, ma di fatti. Piena di piccoli fatti che costruiscono e danno sostanza al concetto.
Sono stata fortunata a crescere in una famiglia che mi ha saputo guidare in questa visione dell’altro-che-non-sono-io. Molto fortunata.
Riflettendo su questo è ovvio che altre culture, altre usanze, altre tradizioni, altre teste possono seguire altre vie – chi più pudiche, chi più sfacciate – e queste differenze possono causare tensioni e fraintendimenti con conseguenze spiacevoli. Possono. Eppure, se mi rifaccio al mio benedetto imprinting, lo posso comprendere e lo posso maneggiare senza per questo pensare che io sono nella ragione e gli altri – quelli diversi da me – nel torto. Perché il mio spazio me lo curo e me lo proteggo senza fare drammi, per piccoli spostamenti. Perché sono un Essere Vivente e in quanto tale sono in perenne movimento, perché la vita si muove dentro di me e con me (a volte anche contro il mio volere, ma sono una pigra, ormai è risaputo).
In poche parole: benvenuti a voi, chiunque voi siate… ma non sbattete la porta, parlate a volume normale e siate discreti, così che io vi possa accogliere sempre con enorme piacere.