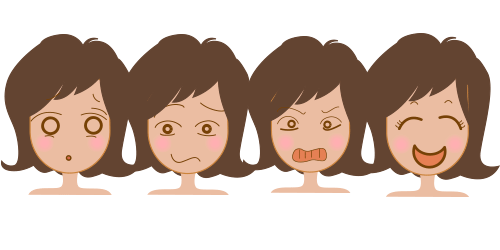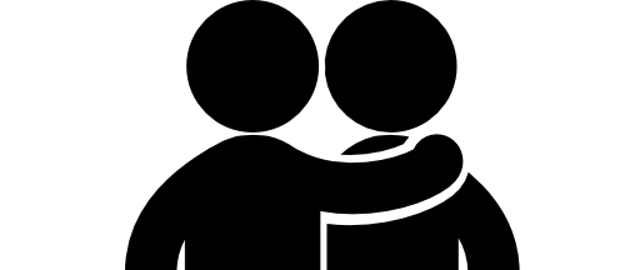racchiudere /ra’k:judere/ v. tr. [der. di acchiudere, col pref. r(i)-] (coniug. come chiudere). – 1. a. [avere dentro, chiudere in sé come in un contenitore: museo che racchiude molte sculture] ≈ (lett.) albergare, contenere, custodire, ospitare. b. [usato spesso al passivo, chiudere formando quasi una delimitazione: il paese è racchiuso fra alte mura] ≈ chiudere, cingere, circondare, circoscrivere, comprendere, delimitare. 2. (fig.) [avere o porre all’interno: questo principio ne racchiude in sé molti altri] ≈ comportare, comprendere, conglobare, contenere, implicare, includere, inglobare, (non com.) rinserrare. ↔ escludere, lasciare fuori.
Chiudere in sé come in un contenitore. Chiudere-in-sé-come-in-un-contenitore. Non credo di avere mai incontrato in un lemma del dizionario una spiegazione così poetica. Siamo un contenitore e chiudiamo dentro di noi talmente tante cose da perderci la testa. E spesso la perdiamo davvero.
Conteniamo il passato, il nostro personale e quello dell’Umanità intera, il presente e il futuro che è soltanto congetture e ipotesi e illusioni, ma che pesano come cemento e che possono ancorarci al suolo senza neppure poter alzare la testa per guardare il cielo. Conteniamo tutto quello che ci è stato detto e il sentimento con cui quelle cose sono arrivate a noi, spesso come mazzate, alcune come carezze. E conteniamo tutte le bugie, tutte le sporcizie, tutte le schegge del nostro amor proprio andato in fratumi almeno mille volte o mille di più di quello che avremmo voluto e che avremmo auspicato per noi stessi.
Conteniamo anche tutto quello che non vogliamo condividere con gli altri, per paura di essere sbeffeggiati e derisi e mortificati. Sono solitamente cose belle, cose che farebbero nascere sorrisi e piccole gioie, ma soltanto in poche anime e rischiare troppo non si può, non ce lo si può permettere.
Conteniamo immagini a non finire che potremmo frammentare in istanti e farne un film lungo una vita o due o anche tre. Conteniamo suoni che attraversandoci si sono soffermati un po’ più del dovuto e hanno marchiato le nostre cellule che ancora vibrano senza sapere ormai il perché. Conteniamo rinascite e continue morti. Conteniamo partenze e ritorni, contorni di addii e convinti arrivederci.
E poi ci sorprendiamo se non ci ricordiamo dove abbiamo messo le chiavi dell’auto o gli occhiali o il cellulare… ma chi se ne importa? Prima o poi li ritroveremo esattamente dove li abbiamo posati, ma come si fa a rinunciare a quello che stiamo contenendo? Come si fa a scegliere cosa buttare e cosa tenere? Come si fa ad allontanarsi credendo che saremo ancora gli stessi?
E come si può rischiare che non sia così?
Io non posso.